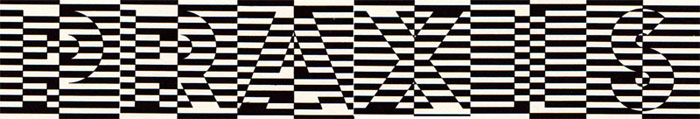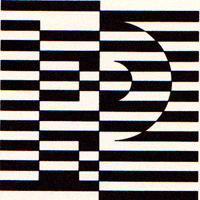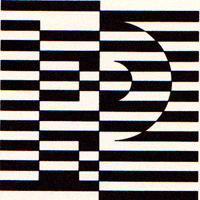Federico Leoni
L'uno. Archeologia della psicoanalisi
La psicoanalisi incontra a un certo punto del suo tragitto la questione dell'Uno. Jacques Lacan la mette anzi al centro dell'ultima fase della sua riflessione e della sua pratica clinica. Ma le letture contemporanee di Lacan si dividono in profondità proprio su questo punto. Alcune fuggono l'autismo dell'Uno, altre se ne fanno persino sedurre, arrivano a ipostatizzarlo, non meno delle prime, del resto. Questa divisione è esemplare, persino sintomatica. Interrogarla, come può fare un'archeologia dei saperi e delle pratiche contemporanee, può far luce sul senso e sui limiti di molte delle scienze umane, al cui campo la psicoanalisi appartiene esemplarmente anche se problematicamente. Soprattutto, può fare luce su molte delle trasformazioni a cui vanno incontro le forme e i contenuti della nostra esperienza, e sull'Uno come operatore fondamentale di ogni esperienza come di ogni teoria dell'esperienza.
Federico Leoni insegna Antropologia filosofica all’Università di Verona. È coordinatore scientifico del Centro di ricerca per la filosofia e la psicoanalisi istituito presso il Dipartimento di scienze umane della stessa Università. Tra i suoi libri: L’inappropriabile. Figure del limite in Kant (2004); Senso e crisi. Del corpo, del ritmo, del mondo (2005); Habeas corpus. Sei genealogie del corpo occidentale (2008); L’idiota e la lettera. Quattro saggi sul ‘Flaubert’ di Sartre (2013); Jacques Lacan, l’economia dell’assoluto (2016). Dirige con Massimo Recalcati la rivista “Lettera. Quaderni di clinica e cultura psicoanalitica”. Dirige con Riccardo Panattoni la serie “Le parole della psicoanalisi” (Orthotes, Salerno). Dirige con Mauro Carbone, Galen Johnson e Ted Toadvine la rivista internazionale “Chiasmi” dedicata al pensiero di Maurice Merleau-Ponty.
__________________________________________________________________________
Graziano Lingua
L’Uno e i suoi Altri
Figure e temi del pensiero trinitario nel cristianesimo orientale
Il cristianesimo si è pensato fin dalle origini sotto il segno dell’Incarnazione e quindi sotto il segno di un Uno che si presenta come originaria relazione tra il Padre e il Figlio. L’unico quadro concettuale che ha permesso di concepire questa relazione è stata la figura uni-trinitaria di Dio. La concezione cristiana della Trinità implica che l’unità dell’ousia-sostanza di Dio si dia al proprio interno nella sussistenza ipostatica dei Tre, con le loro azioni specifiche. Nella lezione cercherò di far emergere alcune strutture concettuali che sono state utilizzate per dire la differenza delle persone nell’obiettivo di mantenere unito ciò che esse allo stesso tempo permettono di distinguere. Per fare questo lavorerò su uno specifico corpus della tradizione del cristianesimo orientale, perché è in esso che il problema dell’uni-trinitarietà ha trovato un contesto speculativo particolarmente fecondo. Oggetto del mio intervento sarà nello specifico la teologia trinitaria dei Padri cappadoci (Basilio e Gregorio di Nissa) e la ripresa del problema trinitario nella filosofia religiosa russa di inizio novecento (S. N. Bulgakov e P. A. Florenskij).
Bibliografia
Gregorio di Nissa, Contro Eunomio, in Id., Opere dogmatiche, a cura di C. Moreschini, Bompiani, Milano 2014
Basilio, Lo Spirito Santo, a cura di Giovanna Azzali Bernardelli, Città Nuova, Roma 1998.
S. N. Bulgakov, Capitoli sulla trinitarietà, trad. it. di G. Lingua, in P. Coda, Sergej Bulgakov, Morcelliana, Brescia 2003
P.A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, a cura di N. Valentini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010.
Graziano Lingua è professore associato presso l’Università di Torino, dove insegna filosofia teoretica e antropologia filosofica. Dopo aver conseguito il Magistero in Scienze religiose presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano (sez. di Fossano), si è laureato in Filosofia ed ha ottenuto i dottorati in Ermeneutica e in Scienze Giuridiche presso l’Università di Torino. Si è occupato in particolare di filosofia della religione e di teorie dell’immagine. Negli ultimi anni ha poi lavorato sul tema della secolarizzazione e sul rapporto tra religioni e politica.
__________________________________________________________________________
Claudio Paolucci
Linguaggio ed esperienza: una prospettiva semiotica
In questa lezione affronterò il problema del rapporto tra linguaggio ed esperienza da una prospettiva semiotica, mettendo in relazione questo problema con le idee di struttura, molteplicità, unità e categorizzazione.
Partirò dall’idea di Deleuze secondo cui lo strutturalismo nasceva in opposizione alla fenomenologia e, in particolar modo, all’idea di “un’esperienza selvaggia”, di tipo precategoriale, che poneva il visibile come base dell’enunciabile e del discorsivo. Da qui introdurrò l’idea di struttura e la collegherò all’idea di complessità, fornendo una definizione rigorosa di entrambe e lavorando sulla costituzione essenzialmente discorsiva che è propria dell’idea stessa di struttura.
Mostrerò come la semiotica sia fin dalle sue origini il tentativo di articolare questo rapporto tra dicibile e visibile sotto l’egida di un primato del dicibile e userò la Logica dei Relativi di Peirce per strutturare un modello di questa “dicibilità”. Questo mi consentirà di pensare al rapporto tra linguaggio ed esperienza come alla costruzione di una complessità irriducibile sia all’unità che ai rapporti binari tra coppie.
Testerò infine questa mia ipotesi lavorando sull’idea di cognizione sociale e sul concetto di “intersoggettività”, introducendo una possibile articolazione narrativa della struttura propriamente “dicibile” attraverso cui attribuiamo senso all’esperienza. Testerò questa mia ipotesi attraverso gli ultimi dati provenienti dalle così dette “scienze cognitive”.
Bibliografia
G. Deleuze, Lo strutturalismo, Milano, ISEDI (già “Da che cosa si riconosce lo strutturalismo?”).
G. Deleuze, Foucault, Milano, Feltrinelli.
M. Merleau-Ponty, Segni. Fenomenologia e strutturalismo, linguaggio e politica, Milano, Il Saggiatore.
C. S. Peirce, Categorie, Roma-Bari, Laterza.
C. Paolucci, Strutturalismo e interpretazione, Milano, Bompiani.
S. Gallagher e D. Zahavi, La mente fenomenologica, Milano, Cortina.
C. Paolucci, “Social cognition, mindreading and narratives. A cognitive semiotics perspective on narrative practices from early mindreading to Autism Spectrum Disorders”, May 2018.
Claudio Paolucci è professore associato di Semiotica e Filosofia del linguaggio all'Università di Bologna ed è vice coordinatore del dottorato di ricerca in Philosophy, Science, Cognition and Semiotics del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna. Studioso di Peirce e Hjelmslev, si occupa principalmente di semiotica generale, scienze cognitive, pragmatismo, interpretazione e teoria dei linguaggi.
Dal 2012 è il segretario della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio e dal 2014 è il coordinatore scientifico della Scuola Superiore di Studi Umanistici dell'Università di Bologna fondata da Umberto Eco, che ne è stato il presidente fino alla sua morte nel 2016.
È stato visiting scholar presso l'École des hautes études en sciences socials (EHESS) di Parigi (2003 e 2004), visiting researcher presso il Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée (CREA) di Parigi (2012) e visiting professor presso le Università di Parigi, Olomouc, Praga, Liegi e Memphis (2016 e 2018, prof. S. Gallagher). Dal 2005 è stato tutor e consulente scientifico del dottorato di ricerca in Semiotica dell'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) ed è vice direttore della rivista internazionale di semiotica VS-Versus, redattore della rivista internazionale Nouvaux Actes Sémiotiques e membro del comitato di direzione dell'Italian Journal of Cognitive Sciences.
Dopo la tesi di dottorato sulla semiotica interpretativa nel 2005 (relatore prof. Umberto Eco), ha tenuto su invito cicli di lezioni e di seminari presso le università di Parigi (CREA, EHESS, Sorbonne), San Paolo (PUC), Sofia, Palermo, Tolosa, Messina, Limoges, Teramo, Madrid, Liegi, Milano, Urbino, Boston (Lowell University), Catania, Olomouc, Memphis, Trento e Praga (Circolo Linguistico). Autore di numerose pubblicazioni internazionali, la sua opera più importante è Strutturalismo e interpretazione (Bompiani, 2010, 544 pp.).
Nel 2016 ha ottenuto un finanziamento ministeriale per un progetto strategico di interesse nazionale (PRIN 2015) su “Cognizione e performatività”, di cui è il responsabile dell’unità di UNIBO. In precedenza ha vinto diversi grants, tra cui un importante progetto di partnership del 7PH. Dal 2016 è uno dei tutori attivi del Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Nel 2017 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario.
__________________________________________________________________________
Felice Cimatti
L'impossibilità di un pre-linguistico: Wittgenstein e Lacan
L'animale umano è umano perché parla. Più propriamente, il corpo umano è 'parlato' da prima di nascere. Questo significa che non c'è alcuna esperienza umana - corporea, estetica, mistica - che non sia segnata da questo attraversamento. Quindi, non esiste alcun ambito o capacità - nel sapiens - che più o meno direttamente si possa qualificare come pre- o non-linguistica. La principale conseguenza di questo dato di fatto antropologico è che all'umano è preclusa ogni forma di relazione diretta con il mondo, perché fra sé e il mondo c'è sempre il filtro del linguaggio, e quindi della rappresentazione. L'umano, pertanto, è l'essere della mediazione e della separatezza. In questo intervento si discuterà come Wittgenstein prima, e Lacan poi, abbiano provato a pensare il problema di una esperienza umana 'oltre' il linguaggio.
Bibliografia
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi;
Ludwig Wittgenstein, "Conferenza sull'etica", in LEZIONI E CONVERSAZIONI sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, Adelphi
Jacques Lacan, Seminario VI. Il desiderio e la sua interpretazione, Einaudi
Jacques Lacan, "Seminario su La lettera rubata", in Scritti, vol. I, Einaudi
Felice Cimatti insegna Filosofia del Linguaggio all'Università della Calabria. Fra le sue pubblicazioni Il senso della mente. Per una critica del cognitivismo (Bollati Boringhieri), Il volto e la parola. Per una psicologia superficiale (Quodlibet),
Il possibile e il reale. Il sacro dopo la morte di Dio (Codice), Naturalmente comunisti. Linguaggio, politica ed economia (Bruno Mondadori), La vita che verrà. Biopolitica per Homo sapiens (ombre corte), Filosofia dell’animalità (Laterza), Il Taglio. Linguaggio e pulsione di morte (Quodlibet). Ha curato, insieme a Silvia Vizzardelli, Filosofia della psicoanalisi. Un'introduzione in ventuno passi (Quodlibet), con Alberto Luchetti Corpo, linguaggio e società (Quodlibet) e con Leonardo Caffo A come animale. Per un bestiario dei sentimenti (Bompiani). Co-dirige la Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio (http://www.rifl.unical.it/), è uno dei fondatori del Centro Studi Interdipartimentale Filosofia e Psicoanalisi presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria (http://centrostudifilosofiaepsicoanalisi.unical.it/).
__________________________________________________________________________
Guido Cusinato
Filosofia come esercizio di trasformazione
In questo intervento mi propongo di ripensare la filosofia come esercizio di trasformazione. A questo fine analizzo il concetto di “trasformazione", distinguendolo da quello di “adeguazione" e mettendo in discussione il tradizionale rapporto fra il possibile e il reale.
Bibliografia
G. Cusinato, Trasformazione e germinazione, in: Numero monografico della rivista Thaumàzein, pp. 37-67, il PDF è scaricabile gratuitamente al seguente link: http://thaumazein.it/la-rivista/
Guido Cusinato si è laureato in Filosofia all'Università di Bologna con Enzo Melandri. Ha conseguito un dottorato di ricerca in "Etica e filosofia politica" a Salerno e le abilitazioni scientifiche nazionali (ASN) di Prima fascia in Storia della filosofia, in Filosofia morale e in Filosofia teoretica.
Ha svolto per una decina d'anni attività di ricerca e d'insegnamento all'estero in collaborazione con il Prof. Wolfhart Henckmann (Ludwig Maximilians Universität, München), con il Prof. Manfred Frank (Eberhard Karls Universität, Tübingen), con il Prof. Wilhelm G. Jacobs e il Prof. Jörg Jantzen (Schelling Kommission, Bayerische Akademie der Wissenschaften) e con il Prof. Manfred Frings (DePaul University, Chicago).
Rientrato in Italia, dal 2005 è docente all'Università di Verona. Dal 2013 al 2018 è stato Presidente della società internazionale "Max-Scheler-Gesellschaft" (Köln, Deutschland). Dirige la rivista di filosofia "Thaumàzein" e la collana "Etica e filosofia della persona" della FrancoAngeli. Del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona ha diretto il Master in "Consulenza Filosofica di Trasformazione" e dirige il Centro di ricerca "FormaMentis". Intende la filosofia come un esercizio di trasformazione e ha sviluppato una teoria della singolarità personale partendo dai temi dell'emotional sharing e dell'espressività intercorporea. Principali temi di ricerca: fenomenologia delle emozioni, fenomenologia delle relazioni di cura e dell'alterità, psicopatologia fenomenologica.
Fra le sue ultime pubblicazioni: Person und Selbsttranszendenz. Ekstase und Epoché als Individuationsprozesse bei Schelling und Scheler, Königshausen&Neumann, Würzburg 2012; Periagoge. Teoria della singolarità e filosofia come esercizio di trasformazione, QuiEdit, Verona 2017; Filosofia della nascita, Numero monografico della rivista «Thaumàzein», 2017.
__________________________________________________________________________
Manlio Iofrida
L'Uno, i segni, la storia: temporale e intemporale, singolare e universale in Vico e Auerbach.
Come si declina il tema dell'Uno e dei segni nel campo della storia? La domanda appare urgente oggi, nel momento in cui, dopo i favoleggiamenti di una "fine della storia" della fine del secolo scorso, essa si è rimessa prepotentemente e inquietantemente in moto. Per cercare di ripensare un modello di storia che non ricada nelle secche del vecchio storicismo, mi baserò soprattutto su due classici fra loro molto vicini, Vico e Auerbach, cercando di mostrare come, nella loro riflessione, si articolino in modo nuovo temporale e intemporale, singolare e universale.
Manlio Iofrida insegna Storia della Filosofia Francese Contemporanea e Filosofia della Storia all'Università di Bologna; è autore di molti libri e saggi su Foucault, Derrida e Merleau-Ponty; da molti anni, il fuoco della sua ricerca è costituito dal ripensamento filosofico della visione ecologica. Da un decennio dirige il gruppo di ricerca "Officine Filosofiche", che ha all'attivo la pubblicazione di quattro volumi presso l'editore Mucchi. Principali pubblicazioni: Forma e materia. Saggio sullo storicismo antimetafisico di Jacques Derrida, Pisa, ETS, 1988; Per la storia della filosofia francese contemporanea, Modena, Mucchi, 2007; Foucault en Italie, in Daniele Lorenzini, Arianna Sforzini, Un demi-siècle d'Histoire de la folie, PARIS, Kimé, 2013; (insieme a Diego Melegari) Foucault, Roma, Carocci, 2017; (insieme a Silvano Petrosino), Contro il post-umano. Ripensare l'uomo, ripensare l'animale, Milano, EDB, 2017.
__________________________________________________________________________
Riccardo Manzotti
Una visione critica del fisico per superare la dicotomia soggettivo/oggettivo
La tradizione galileiana ha incoraggiato la distinzione tra il mondo fisico fatto di proprietà oggettive e quindi indipendenti dalla osservazione e il mondo mentale fatto di proprietà soggettive frutto del rapporto con i soggetti. Questa distinzione era già traballante nel momento in cui Galileo stesso riconobbe la relatività della velocità e dello spazio. Nonostante il passo indietro della meccanica Newtoniana, gli sviluppi della fisica del secolo scorso (relatività e meccanica quantistica) rivelano la natura relativistica del fisico. In questo intervento, intendo sfruttare la nozione di relativo a attuale nella fisica per mostrare che la tradizionale dicotomia soggettivo/oggettivo non ha ragion d’essere. Muovendomi in una cornice rigidamente fisicalista, mostrerò che l’oggettivo altro non è che un relativo canonico, e il soggettivo è un relativo al corpo individuale (senza dare al corpo umano alcun privilegio metafisico). Il relativo fisico può quindi essere proposto come quella base ontologica neutra che James aveva indicato nel suo monismo neutrale.
Riccardo Manzotti è professore di filosofia teoretica alla IULM di Milano, filosofo, psicologo e ingegnere, dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in robotica si è sempre dedicato allo studio delle basi fisiche della mente cosciente. In passato si è occupato di percezione, intelligenza artificiale, allucinazioni, estetica, e psicologia dell‘arte, tecnologia e media. Ha svolto attività di ricerca all’estero (Trinity College a Dublino, KAIST in Corea del Sud, Nortwestern University a Chicago) e, nel 2013-2014 è stato Fulbright Visiting Researcher presso l’MIT di Boston. Ha pubblicato decine di articoli in riviste internazionali e numerosi volumi sul tema della coscienza tra i quali Coscienza e realtà (Il Mulino, 2001), L’esperienza (Codice, 2008). Sta per pubblicare due nuovi volumi internazionali sulla sua teoria sulla coscienza:The Mind-Object Identity (John Benjamin) e The Spread Mind (OR Books). Dal 2014 è il sostenitore di una nuova e radicale teoria della coscienza, basata su una nozione relativistica della natura. Attualmente cura una serie di dialoghi a tema filosofico sul New York Review of Books. Il suo lavoro è disponibile su www.consciousness.it.
__________________________________________________________________________
Sandro Palazzo
Immanenza e libertà: alcune note a partire da Fichte e Deleuze
L’intervento intende proporre alcune note intorno alla possibilità di costruire una ontologia trascendentale che si voglia radicale e intorno alla contraddittorietà o meno, nel quadro di siffatta ontologia, delle nozioni di contingenza e libertà. Il filo conduttore sarà offerto da una riflessione sul rapporto tra forma e contenuto dell’apparire, in cui si tenterà di porre in tensione alcuni temi della speculazione fichtiana e di quella deleuzeana.
Bibliografia
J.G. Fichte, Introduzione alla vita beata
G. Deleuze, L’immanenza: una vita…
S. Palazzo, Figure del trascendentale: vita e concetto in Fichte e Deleuze, in«Rivista di filosofia neoscolastica», Gennaio-Giugno 2018
Sandro Palazzo
Dottore di ricerca presso l'università di Bologna, si è perfezionato presso l’École normale supérieure di Parigi. Si è occupato di filosofia francese del secondo Novecento, pubblicando diversi articoli e saggi su Deleuze e Derrida. Ha collaborato con l'Enciclopedia filosofica Bompiani, con Governare la paura. Journal of interdisciplinary studies e con la biblioteca Ambrosiana di Milano. Ha curato la prima traduzione italiana delle lezioni di Deleuze su Kant del 1978 (Fuori dai cardini del tempo, Mimesis 2004) e di Ricerca della base e della vetta di R. Char (Mimesis 2011). In particolare ha approfondito i rapporti tra il pensiero deleuzeano e la filosofia kantiana e postkantiana nella monografia Trascendentale e temporalità (ETS 2013). Ha curato la prima edizione italiana di Logique et existence di J. Hyppolite (Bompiani 2017). Si sta attualmente occupando della speculazione fichtiana negli anni 1804-1806; in proposito ha recentemente pubblicato Figure del trascendentale: vita e concetto in Fichte e Deleuze («Rivista di filosofia neoscolastica», Gennaio-Giugno 2018).
__________________________________________________________________________
Rocco Ronchi
Sulla libertà e la volontà dell'Uno: una riabilitazione del paradigma megarico
“La necessità incondizionata, di cui abbiamo bisogno in maniera così indispensabile, come dell'ultimo sostegno di tutte le cose, è il vero baratro della ragione umana (...) Non si può evitare, ma non si può nemmeno sostenere, il pensiero che un Essere, che ci rappresentiamo come il sommo fra tutti i possibili, dica quasi a se stesso: Io sono ab eterno in eterno; oltre a me non c'è nulla, tranne quello che è per volontà mia; ma donde son io dunque? Qui tutto si sprofonda sotto di noi, e la massima come la minima percezione pende nel vuoto senza sostegno innanzi alla ragione speculativa, alla quale non costa nulla far disparire l'una come l'altra senza il più piccolo impedimento”. Mai, forse, come in questa pagina della Critica della ragion pura, che sembra scritta dalla penna del più stravagante tra i romantici, si è raggiunta una consapevolezza così lucida della inconsistenza della trascendenza. Non è, infatti, la “necessità incondizionata” della metafisica che è capace di superare la prova dello scetticismo ma quello “scambio” immediato, senza distanza né identificazione, senza copula, tra noein ed einai, tra cogito e sum, quella potenza già da sempre atto, che vige come fondamento e come causa di ogni relazione di un soggetto con un oggetto, di ogni domandare come di ogni rispondere.
Rocco Ronchi è ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di L’Aquila. Tiene corsi e seminari in varie università italiane e straniere. Insegna filosofia presso l’IRPA (Istituto di ricerca di psicanalisi applicata) di Milano. Dirige la collana “Filosofia al presente” della Textus edizioni di L’Aquila e la scuola di filosofia Praxis (Forlì). Tra le sue più recenti pubblicazioni: Come fare. Per una resistenza filosofica Feltrinelli, MIlano, 2012; Gilles Deleuze, Feltrinelli, Milano 2015; Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017; Bertolt Brecht, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.
__________________________________________________________________________
Officine filosofiche
è un gruppo di ricerca con sede a Bologna attivo dal 2008 che raccoglie studiosi delle Università di Bologna e di Firenze e studiosi indipendenti. Direttore prof. Manlio Iofrida.
Philosophy Kitchen
è una rivista di filosofia fondata da un gruppo di giovani studiosi dell'Università degli Studi di Torino, che lavorano sotto la supervisione del prof. Giovanni Leghissa. Il nostro intento principale è quello di creare le condizioni ottimali per uno spazio di riflessione filosofica che sia in grado di ospitare, nello stesso tempo e in maniera incondizionata, spunti fecondi provenienti dalle più diverse aree del sapere. Qui, fenomenologia, decostruzione, teoria dei sistemi, filosofie della vita, filosofia del diritto e della giustizia, filosofie interculturali, antropologia filosofica, psicoanalisi e molto altro ancora, troveranno terreno fertile per mettere radici, ma, soprattutto, per fare rizoma.
Centro di Ricerca Tiresia. Filosofia e Psicoanalisi
lavora all’intersezione tra filosofia e psicoanalisi. Le questioni dell’inconscio e della soggettivazione, del trauma e della ripetizione, dell’immagine e della voce sono al cuore di questo incontro tra saperi e pratiche differenti, di cui il Centro esplora convergenze, divergenze, reciproche influenze.
__________________________________________________________________________
|
|